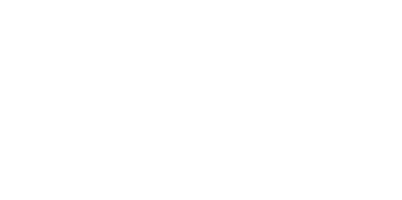Permessi L. 104/1992 e l’ossessione datoriale di “abuso del diritto”. La Cassazione fa chiarezza

di Federico Avanzi
L’ennesima pronuncia
Con l’ordinanza del 17 gennaio 2025, n. 1227, la Corte di cassazione è chiamata, per l’ennesima volta, a pronunciarsi sull’ormai ricorrente fattispecie del licenziamento intimato a causa di un – asserito – utilizzo “distorto” dei permessi riconosciuti al lavoratore subordinato, ai sensi dell’art. 33 L. 5 febbraio 1992, n. 104, «per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità».
Anche in questa occasione, a presupposto dell’avvio dell’iter disciplinare, sfociato poi nel recesso per “giusta causa”, erano gli esiti di un’attività investigativa commissionata dal datore di lavoro e che, nel caso di specie, inducevano ad addebitare al dipendente di aver dedicato al suocero affetto da handicap, nelle cinque giornate oggetto d’indagine, soltanto un’ora di assistenza al giorno, impiegando il resto del tempo a scopi personali altri, insieme alla moglie.
Ma se in primo grado, tenendo conto anche delle attività strumentali e accessorie rispetto alla vera e propria assistenza, nonché il tempo impiegato per recarsi e far ritorno dall’abitazione del coadiuvato, arrivando così ad accertare un monte orario di 16 o 17 ore, dunque pari al 40/42% dell’orario di lavoro “sottratto” all’Azienda, il Tribunale annullava il licenziamento e disponeva la reintegrazione del lavoratore, in fase d’Appello, la Corte territoriale riteneva, invece, legittime e sussistenti le ragioni fondanti il recesso.
In particolare, facendo leva su di un risalente precedente della Cassazione (Cass. 6 maggio 2016, n. 9217), il Collegio del gravame riteneva che la mancata assistenza per due terzi o per almeno la metà del tempo teoricamente lavorativo, integrasse una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, dovendo con ciò ritenersi “spezzato” il nesso causale fra quei permessi e l’assistenza dovuta al familiare disabile.
La nozione di “abuso del diritto”
Ma se immediate, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, appaiono le macroscopiche falle della decisione d’Appello, quantomeno di ancorare il proprio convincimento sul parametro dell’orario di lavoro omesso (in tema, M. Vitaletti, Il tempo di lavoro e le sue articolazioni nella fruizione dei permessi assistenziali, in Riv. giur. lav., 2023, 2) o, comunque, a una valutazione esclusivamente “quantitativa” della condotta contestata al dipendente (sull’approccio “qualitativo” dell’accertamento v. M. Salvagni, Licenziamento disciplinare e abuso dei permessi L. n. 104/92: il tempo dell’assistenza al disabile non si misura con il cronometro, in LPO News 23.09.2024), di maggior e inedito profilo sono, piuttosto, gli approfondimenti riguardo alla nozione di “abuso del diritto” al permesso, operati dal Supremo Collegio, al fine di accogliere il ricorso promosso dal lavoratore e rinviare la gravata sentenza a nuovo esame.
Invero, muovendo da una breve premessa sulle due “dimensioni” che realizzano le finalità sottese all’istituto dei cc.dd. “permessi 104” e che ne legittimano il godimento ossia, da una parte, quella “quantitativa”, comprensiva, all’evidenza, non soltanto delle prestazioni di assistenza diretta alla persona disabile, ma anche di tutte le attività ad esse complementari e accessorie (acquisto di medicinali e il conseguimento delle relative prescrizioni dal medico di famiglia, approvvigionamento di generi alimentari e di altri prodotti per l’igiene, cura della persona e il decoro della vita del disabile o, ancora, partecipazione di quest’ultimo ad eventi di relazione sociale, sportiva, religiosa etc.), dall’altra, quella “qualitativa”, cioè considerando portata e finalità dell’intervento assistenziale offerto dal dipendente (con riguardo al complessivo contesto, anche relazionale, rispetto a eventuali strutture sanitarie, pubbliche o private, presso le quali sia necessario espletare accertamenti o effettuare ricoveri), la Corte di cassazione si sofferma sul senso tecnico-giuridico da attribuire alla nozione di “abuso del diritto”, al solo ricorrere della quale, in effetti, potrebbe configurarsi l’ipotesi di “uso distorto” del permesso.
Come anticipato, a fronte di una precedente esegesi giurisprudenziale, al riguardo, tutt’altro che rigorosa (Cfr. F. Avanzi, L’abuso dei permessi l. 104 e l’incerto “parametro” dell’obbligazione contrattuale, in www.rivistalabor.it, 24 marzo 2023) e tendente a sovrapporre la decisiva quaestio iuris, con il ricorrente rimando alla clausola generale di “correttezza e buona fede” (Cfr. A. Ripepi, La Cassazione torna sul delicato tema dei permessi di cui alla l. n. 104/1992 utilizzati da un caregiver: fu vero abuso?, in www.rivistalabor.it, 25 gennaio 2025), questa volta i giudici della nomofilachia forniscono un’ampia riflessione degli elementi costitutivi la fattispecie abusiva illecita: sul piano “oggettivo”, passando in rassegna, per analogia, norme e istituti presenti nell’ordinamento (art. 833 c.c. relativo agli atti emulativi del proprietario; art. 10-bis L. 27 luglio 2000, n. 212 riguardo vantaggi fiscali indebiti; art. 30 comma 1-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in materia d’immigrazione; in caso di ritardato esercizio delle prerogative del locatore, a danno del conduttore; abuso di “maggioranza” in ambito societario e in ambito fallimentare, sulla proposta concordataria avanzata da terzi, con ingiustificato sacrificio delle ragione del debitore), evidenziando come il concetto di “abuso del diritto” implichi «l’assenza di funzione, ossia un esercizio del diritto solo apparente, privo di qualunque legame ed utilità rispetto allo scopo per il quale quel diritto è riconosciuto dal legislatore»; sul versante “soggettivo”, valorizzando l’elemento psicologico della condotta del lavoratore, intenzionale o dolosa nel voler pregiudicare l’interesse altrui (qui, datore di lavoro e INPS) e necessariamente da accertarsi, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, quali il «tempo “irrisorio” o comunque molto limitato dedicato nella singola giornata all’assistenza al disabile, ovvero sulle particolari connotazioni dell’elemento oggettivo».
E dato che anche solo l’assenza di uno di questi elementi – “oggettivo” e “soggettivo” – impedirebbe la configurabilità di un “abuso del diritto”, ad avviso del Supremo Collegio, due sarebbero le principali ricadute, di siffatti principi, sul caso sottoposto al suo vaglio: In primis, che a «a prescindere da calcoli più o meno esatti [,] la prossimità del tempo dedicato all’assistenza almeno alla metà di quello totale, specie se a quella quantità di tempo si aggiungono i tempi necessari di percorrenza dalla propria abitazione a quella del disabile, si è in presenza di un esercizio del diritto che può essere sussunto nella nozione legale di assistenza al familiare disabile»; da secondo e comunque, l’esigenza di un nuovo controllo di merito, non più calibrato su meri criteri quantitativi, bensì su di una relatività del giudizio mossa dal presupposto «che il c.d. abuso del diritto potrà configurarsi soltanto quando l’assistenza al disabile sia mancata del tutto, oppure sia avvenuta per tempi così irrisori oppure con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate le finalità primarie dell’intervento assistenziale voluto dal legislatore (id est la salvaguardia degli interessi del disabile), in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro ad ottenere l’adempimento della prestazione lavorativa».
Un “chiarezza” necessaria
Ora, ad avviso di chi scrive, nella forte sottolineatura sui reali e certamente “ristretti” confini («quando l’assistenza al disabile sia mancata del tutto, oppure sia avvenuta per tempi così irrisori oppure con modalità talmente insignificanti») circa l’ipotesi di abuso dei permessi in parola, sembra potersi leggere, in controluce, pure l’intenzione della Corte di cassazione di porre un freno a quella sorta di ossessione, certamente favorita dallo sdoganamento dei cc.dd. “controlli occulti” (dispiegabili in tutti i casi di verifica inerente a comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti, quali l’ampissima fattispecie della truffa. Cfr. Cass. 24 ottobre 2024, n. 27610), che sembra aver animato le invettive datoriali nei riguardi dei dipendenti al contempo caregiver familiari, oggi, al contrario, destinatari della massima protezione da parte dell’ordinamento (Cfr. art. 2-bis, comma 1 L. 5 febbraio 1992, n. 104).
Questo anche perché, come è del tutto logico, una situazione di denunciata anomalia nell’esercizio di diritti soggettivi potestativi da parte di quest’ultimi o affermazioni come di essere innanzi a «una delle fattispecie più abusate dell’intero ordinamento» (così R. Maurelli, I “furbetti della 104”: fruizione abusiva dei permessi per l’assistenza ai familiari disabili e anomalie del sistema, in www.rivistalabor.it, 14 giugno 2023), non dovrebbero fondarsi su mere percezioni, bensì essere supportate o trovare un qualche riscontro nell’evidenze fornite dagli esiti, definitivi, delle vicende giudiziarie.
E a ben vedere, una breve analisi delle precedenti decisioni della Corte di cassazione in argomento, rintracciate, ancorché senza pretesa di esaustività del repertorio, dal 2018, sembra raccontare ben altro.
Invero, a fronte di 19 pronunce, passate in giudicato, favorevoli al lavoratore (Cass. 2 ottobre 2018, n. 23891; Cass. 27 novembre 2018, n. 30676; Cass. 20 agosto 2019, n. 21529; Cass. 22 ottobre 2019, n. 26956; Cass. 19 giugno 2020, n. 12032; Cass. 12 agosto 2020, n. 16930; Cass. 25 settembre 2020, n. 20243; Cass. 26 ottobre 2020, n. 23434; Cass. 2 marzo 2022, n. 6796; Cass. 26 aprile 2022, n. 13065; Cass. 25 maggio 2022, n. 16973; Cass. 24 agosto 2022, n. 25290; Cass. 13 marzo 2023, n. 7306; Cass. 23 marzo 2023, n. 8306; Cass. 9 maggio 2024, n. 12679; Cass. 9 agosto 2024, n. 22643; Cass. 9 settembre 2024, n. 24130; Cass. 10 ottobre 2024, n. 26417; Cass. 29 novembre 2024, n. 30722) e 2, alla stregua di quella qui annotata, cassate con rinvio (Cass. 25 gennaio 2023, n. 2235; Cass. 11 ottobre 2024, n. 26514), solo 9, dopo l’intero iter processuale, hanno invece constatato gli estremi di “abuso di diritto” e la conseguente legittimità del licenziamento irrogato (Cass. 18 febbraio 2019, n. 4670; Cass. 25 marzo 2019, n. 8310; Cass. 22 gennaio 2020, n. 1394; Cass. 16 giugno 2021, n. 17102; Cass. 18 ottobre 2021, n. 28606; Cass. 2 novembre 2023, n. 30462; Cass. 12 marzo 2024, n. 6468; Cass. 3 maggio 2024, n. 11999; Cass. 30 gennaio 2025, n.2157).
Dunque, dati alla mano, una “chiarezza” sulla fattispecie quantomai necessaria, specialmente, si direbbe, per il datore di lavoro, il quale dovrà, dunque, fare i conti, senza che ciò posso assumere alcun rilievo disciplinare, con una quotidianità del lavoratore caregiver “normale” ossia libera – per quanto possa esserla quella di un soggetto di tale incombenza onerato – , al pari di ogni altro giorno, «di graduare l’assistenza al parente secondo orari e modalità flessibili che tengano conto, in primis, delle esigenze dell’handicappato; il che significa che nei giorni di permesso, l’assistenza, sia pure continua, non necessariamente deve coincidere con l’orario lavorativo, proprio perché tale modo di interpretare la legge andrebbe contro gli stessi interessi dell’handicappato» (Cfr. Cass., Sez. II Pen., 23 dicembre 2016, n. 54712).